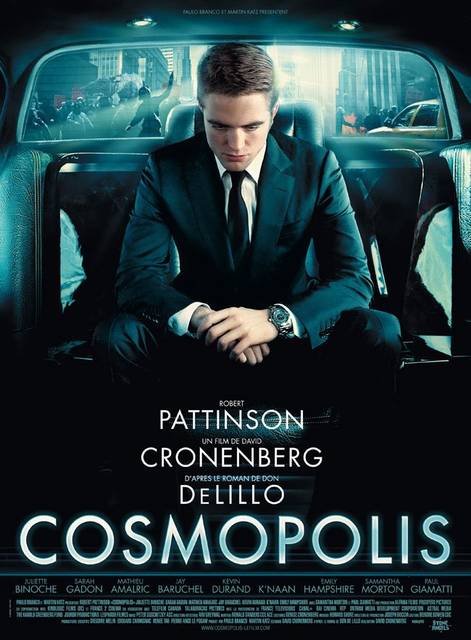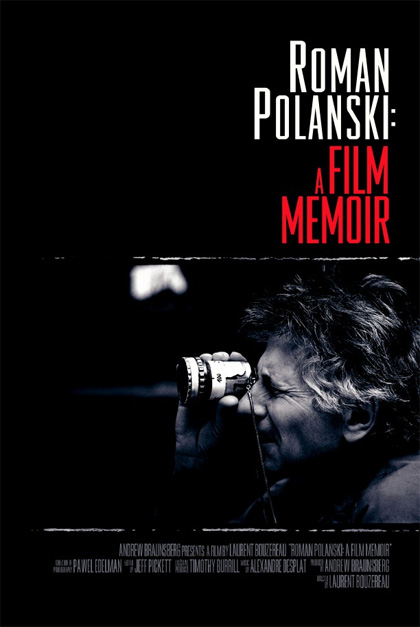La
zona centro occidentale della Russia vicino al Lago Nero era un tempo
abitata dai Merya, una popolazione Ugro-Finnica che fu assorbita
attorno al XVII Secolo dagli Slavi.
Ma
un'etnia non muore finchè ricorda la propria lingua e le proprie
tradizioni.
Aist
acconsente di buon grado ad accompagnare il suo datore di lavoro
Miron per aiutarlo a trasportare il corpo di sua moglie Tanya, appena
defunta, fino a dove la terra incontra il mare: è là che cremeranno
il suo corpo e ricongiungeranno le sue ceneri e la sua anima ai
flutti, che le restituiranno una “nuova dimensione”.
“Silent
souls” di Aleksei Fedorchenko, in originale “Ovsyanki”,
dal nome dei piccoli uccelli – in italiano “Zigoli” - che
accompagneranno nel lungo viaggio i due protagonisti e ne segneranno
il destino, è un'immersione
garbata in un mondo distante del nostro tempo presente.
Tradizioni
e tenerezze sopravvivono alla loro sconfitta rispetto alla storia ed
alla modernità: i Merya, ultimi testimoni di un mondo, uomini
dalle facce inespressive e dalla memoria lunga, che non si lasciano
travolgere dalla passione e nemmeno sedurre dagli enormi ed imponenti
scaffali pieni di merci del “nuovo mondo”.
Provengono
da culture lontane e se non sapranno combattere o resistere chi
vuole cancellarne l'esistenza sanno già di poter assaporare il
futuro rifugio della morte o meglio dell'incontro con “l'acqua”,
che a tempo debito farà la sua scelta e fornirà il suo giudizio
superiore.
Durante
il viaggio tramutano il dolore in “fumo” - così usano
chiamare le esternazioni fatte agli amici sulla vita coniugale e
sessuale riguardante il consorte defunto – ed in qualche modo
perpetuano l'esistenza di chi non c'è più, trasmettendo ricordi che
possano farlo sopravvivere anche attraverso gli altri.
Fedorchenko
ci porta in viaggio seguendo con il suo obiettivo le lunghe strade
che si snodano tra boschi e mare e regalandoci istantanee arcaiche
e seducenti, che sanno irradiare tanto la nitidezza come l'opacità,
grazie ad una fotografia sincera e bellissima (Premio Osella a
Venezia nel 2010).
Aleggiano
tristezza e nostalgia - la stessa “Nostalghia” che il cinema ha
già incontrato grazie ad Andrej Tarkovskij - però non la
disperazione che sembra esser ricacciata indietro da fortissime ed
invidiabili consapevolezze identitarie, dai ricordi poetici e
struggenti che uniscono e cementano e se un giorno sarà inevitabile
soccombere, allora ci si tufferà nelle cristalline liquidità
dell'universo che apre le sue porte in terra giusto sulla superficie
delle acque chiare.
E'
un viaggio intimista ma vitale, di un cinema che vuole testimoniare
di esser presente e con la sua specifica ed irrinunciabile lentezza
porgere a fruitori lontani e diversi l'insieme delle sue delicatezze
e dei suoi costumi.
Risuonano
lontani echi e riflessioni sull'immortalità; più vicini ed intensi
quelli sullo struggimento del distacco e riguardo l'ipotesi benevola
ma incerta del ricongiungimento.
In
“Silent souls” anche la figura della donna, prostitute comprese,
nonostante in un primo momento sembri venir considerata solo nella
sua subalternità rispetto al maschio, viene omaggiata, descritta
come “un fiume che può portare via il dolore: peccato che non ci
si possa annegare dentro”.
Affogare
suicida per un Merya è impossibile, inimmaginabile, come voler
correre al paradiso prima degli altri: è sempre il fiume, semmai,
che deve decidere quando e come.
Il
film di Fedorchenko è romantico e poetico, di una ricercatezza
semplice, denso di immagini e parole in grado di imprimersi nella
nostra memoria e che torneranno a trovarci a posteriori,
regalandoci un retrogusto capace di esaltare il palato con sapori
tenui ed inconsueti e che non desiderano prevaricare con i loro
aromi.
Un
“viaggio primario”, da intraprendere anche solo per visitare le
terre della nostra curiosità: così distante dai nostri confini
e dalle nostre abitudini eppure così vicino a tutti i dubbi ed il
sentire della nostra anima.