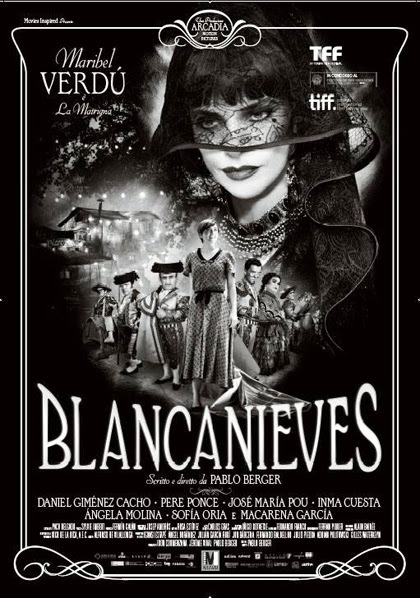Pioggia
battente in una città deserta: soli, all’interno di un teatro -
come all’alba di un nuovo inizio - un uomo e una donna.
Thomas
(Mathieu Amalric), uno scrittore/regista che sta facendo audizioni
per la sua pièce si imbatte (casualmente?...) in Vanda (Emmanuelle
Seigner), una attrice energica ed irriverente in grado di dare nuova
forza alle parole del suo lavoro ed al tempo stesso di stravolgerne
il senso.
La
rappresentazione in questione è tratta dal celebre romanzo “Venere
in pelliccia”, scritto nel 1870 dallo scrittore Austriaco Leopold
Von Sacher Masoch, da cui il termine “masochismo” ed a cascata
tutto un universo sensuale, cerebrale ed erotico “sui generis”.
Allacciare
il vestito di scena all’aspirante protagonista – apparentemente
meno sfrontata e “pericolosa” di quanto non si rivelerà poi -
sarà solo il primo passo verso un insolito confronto/scontro
basato su un vorticoso e continuo ribaltamento di ruoli tra maschio
e femmina, tra regista ed attore, tra chi detta le regole e chi
invece “sembrerebbe” dover solo eseguire gli ordini.
Polanski
sta innegabilmente vivendo una splendida terza età cinematografica:
ha compiuto ottanta anni appena lo scorso 18 agosto e continua ad
inanellare prove registiche che, a giudicare dai risultati, pongono
il suo finale di carriera ben al riparo da una definitiva
conclusione.
Dopo
i quattro attori in una stanza di “Carnage” - basato sull’opera
“Il dio del massacro” di Yasmina Reza - ancora un film tratto da
un testo teatrale, stavolta di David Ivens e sceneggiato per il
cinema a quattro mani da Polanski con lo stesso autore della pièce.
Due solamente i protagonisti, per l’appunto la Seigner ed Amalric,
entrambi bravissimi!
Il
palco diviene ben presto qualcosa di simile ad un ring sopra il quale
“recitare una boxe” dai colpi finissimi ed eleganti, dove
rivelare le passioni negate e comunicare – magari attraverso
particolari codici - i propri pensieri nascosti: tutto il teatro
è niente altro che un labirinto nel quale inoltrarsi verso gli
sconosciuti confini dei propri limiti.
Quello
che va in scena è un duello delizioso, una sfida delle
intelligenze e della provocazione dove, continuamente, vengono
gettati in faccia al proprio “avversario” perfidi guanti di sfida
verbale.
Seguendo
le tracce antiche di un testo che viene da un tempo remoto – nel
quale però già le sole parole scritte da Von Sacher Masoch
trasudavano erotismo – i due protagonisti attualizzano e
rinnovano i significati e le pulsioni che questo è in grado di
scatenare. Dalla finzione sconfinano nella realtà, dapprima
ad intermittenza e cammin facendo sempre più con soluzione di
continuità, scoprendo quanto per entrambe le condizioni ben si
attaglino i medesimi dialoghi e gli scambi di battute, constatandone
la loro ambivalenza ed ambiguità!
Le
inversioni di ruolo e i giochi di specchi sono molteplici ed
illuminanti e confondono la figura dell’uomo e della donna i quali,
in un singolare “testa a testa”, si producono in scivolose
capriole e suggeriscono numerosi rovesciamenti del punto di vista.
Verrà
sottoposto a rivisitazioni insolite anche lo stesso romanzo di Von
Sacher Masoch mentre Thomas e Vanda intraprenderanno percorsi
di pura avventura ed esplorazione, fin dentro meandri mai
visitati neppure da loro stessi.
Polanski
ed i suoi due protagonisti giocano, “si divertono e divertono”
per poi all’improvviso affondare i colpi con precisione quasi
chirurgica, trovando la misura perfetta – grazie soprattutto al
testo di Ivens - per analizzare le relazioni tra sesso e
dominazione ed i rapporti tra impulsività e ragione, unendoci anche
estemporanei lampi di lotta di classe.
La
complessità della tematica principale emerge con chiarezza assieme
ai misteri del temperamento umano ed il tutto viene condito anche
con un essenziale tocco di ironia, perfettamente funzionale a
disinnescare le tensioni ed i toni più accesi o, talvolta, quelli
avviati a sbilanciarsi troppo verso un tenebroso erotismo.
Senza
dubbio il confronto tra Vanda, che si presenta come una donna
semplice e volgarotta (certo per furbizia e comodità: ma di chi si
tratterà veramente?...) ed il più acculturato Thomas - che ha
addirittura un cane chiamato Derrida, come il filosofo Francese - già
è fonte di ilarità; poi nei momenti meno opportuni arriva l’eco
della bizzarra suoneria di un telefono cellulare ad interrompere le
situazioni più cupe o bollenti, ovviamente al ritmo delle note de
“La cavalcata delle Valchirie” di Wagner.
In
un’ora e mezza si spazia dentro le accese complicanze delle
relazioni tra uomo e donna, guardando alle gioie ed alle sofferenze
degli amanti, esplorando luoghi reconditi e mettendo a nudo più
l’anima che i corpi. Su un altro fronte parallelo assistiamo al
confronto del regista alle prese con l’ “insubordinazione”
dell’attore che, talvolta, si rivela straripante e vincente al
punto da costringerlo ad abdicare dal suo ruolo, fino a cedergli “lo
scettro ed il mestiere”.
La
sensazione finale che si ricava da “Venere in pelliccia” è
un volo d’angelo di rara grazia ed armonia che supera, in forma
d’arte, le convenzioni e l’ordinario e dove l’unica
certezza, per quanto declinata spesso con grande senso dell’ironia,
sembra esser quella velata supremazia della donna sull’uomo,
decisa da chissà “chi” e fin dall’alba dei tempi in ossequio
alla citazione biblica dal libro di Giuditta che recita “...e il
signore onnipotente lo colpì e lo mise nelle mani di una donna”.
E
così sia.
.jpg)